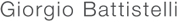-
Conversazione con Stefano Catucci
Stefano Catucci – Il titolo dell’edizione di quest’anno, Oltre la linea, richiama quello di un celebre confronto tra Ernst Jünger e Martin Heidegger, due saggi che scrissero ciascuno come omaggio all’altro ma che riflettono impostazioni differenti. Jünger era stato il primo a usare l’immagine della «linea» come diagnosi della condizione del presente. Nel suo scritto, che risale al 1949, la «linea» viene descritta come una soglia, un «meridiano zero», un limite che bisognava provare ad attraversare, a superare, per coltivare almeno la «speranza» di un commiato dall’epoca del nichilismo: il «grande tema» che aveva occupato la scena della cultura europea «da cent’anni a questa parte». Per Heidegger, il quale risponde al saggio di Jünger nel 1955, occorre invece esercitare una riflessione «sulla linea» per esplorarne lo spessore metafisico, preparando il terreno alla possibilità di un attraversamento che a lui appariva ancora prematuro. Heidegger gioca sul doppio senso dell’espressione tedesca Über die Linie, che si può leggere sia come un invito ad andare al di là della linea (trans lineam), sia come appello a rimanere sulla linea del nichilismo per «localizzarla» con precisione e interrogarla a fondo (de linea). Dal confronto fra quei giganti del pensiero emergono due atteggiamenti possibili nei confronti dell’individuazione della «linea», uno orientato verso l’oltrepassamento, l’altro verso lo scavo e l’approfondimento. So che come compositore sei molto legato a Jünger, che hai avuto contatti diretti con lui quando lavoravi all’opera Auf den Marmorklippen (Le scogliere di marmo) e in occasione di un lavoro orchestrale, Anarca. Ma immagino anche che la scelta di questo titolo per la Biennale Musica sia da leggere in sequenza con quello dell’edizione precedente, Va pensiero. Da un invito alla musica perché restituisca valore al pensiero si passa ora a un’indicazione ideale, e quasi di poetica, che però si può intendere in due direzioni, oltrepassamento o approfodimento. Bisogna scegliere fra queste due alternative oppure è possibile tenerle insieme?
Giorgio Battistelli - Credo che oggi le due maniere di guardare alla linea, per oltrepassarla o per scavare su di essa, coesistano di fatto. Del resto anche Heidegger scriveva a Jünger, e non si trattava solo di un omaggio di circostanza, che le loro riflessioni si implicavano l’una con l’altra, dipendevano l’una dall’altra. Oggi viviamo in una realtà fatta di linee molteplici, non solo quella del nichilismo, che si cristallizzano e rappresentano altrettante occasioni di pensiero. In campo musicale ci sono compositori che si muovono per così dire in orizzontale, cercando di andare oltre le linee nelle quali si imbattono, e altri che agiscono in verticale, approfondendo il punto al quale sono giunti. Quello che mantengo dell’analisi di Jünger – e, come lui, lo faccio senza pessimismo – è l’impressione della soglia: siamo giunti a un confine, a un passaggio fra il “non più” e il “non ancora”. Un pensiero musicale che ci aveva accompagnato per più di un secolo è finito. Il nostro orecchio e il nostro cervello sono sottoposti a continue trasformazioni dell’orizzonte percettivo. Nuove tecnologie e nuovi media costringono a modificare il nostro atteggiamento nei confronti della musica. Non si tratta solo di trasformazioni sociologiche, ma estetiche e antropologiche. Il problema è come ci si relaziona con la musica e come questa è capace di interpretare il presente, di tradurlo in suoni. Il perimetro degli spazi proiettivi a cui la musica può dare accesso si è molto ampliato e non ci sono più forme codificate dalla storia che forniscano un baricentro al quale attenersi. Si potrebbe dire, con uno slogan, che l’informel est partout, che siamo sottoposti a operazioni di smaltimento di materiali sonori a getto continuo. E il musicista si trova a operare all’interno di orizzonti mobili, non statici, intrecciati, non separati. Dal punto di vista di una poetica, questo significa che non ci sono ricette da applicare e che ogni nuova proposta rischia di essere logorata in tempi sempre più rapidi dalla velocità del consumo e della comunicazione, con l’effetto di un’omologazione che non si limita ad appiattire la musica, ma la rende indifferente, e di fatto inutile. La soglia di cui parlo è come una corda fatta con l’intreccio di molte fibre. Ma proprio l’immagine della corda ci riconduce a quella della linea. Oltre la linea è perciò un titolo che indica per un verso un movimento di emancipazione dalla Linea, dall’idea che esista un modo giusto di fare musica, di interpretare il presente con la musica, ma per un altro indica l’insieme di tutte le fibre che compongono la linea con la quale i musicisti devono fare i conti, per oltrepassarla o per dipanarne l’intreccio.
Catucci – La musica non è la sola arte a trovarsi in questa situazione liminare, come di fronte a una soglia.
Battistelli – No, certo, è un problema comune anche ad altre arti. E questa semmai è una constatazione che serve a sottolineare come la musica non sia qualcosa di separato, un’isola rispetto al mondo dell’arte o della cultura in genere. L’omologazione è un rischio che corrono anche altre pratiche artistiche. Nella musica però l’individuazione di un’esperienza rivelatrice, che abbia il valore di un punto d’incontro significativo per l’ascolto, è oggi particolarmente difficile. Le procedure di logoramento sono tanto più rapide quanto più un’arte è sensibile alle trasformazioni della tecnologia, e la musica lo è. Nella musica ci sono realtà che obbediscono a leggi fisiche e formali di tipo diverso, che viaggiano a velocità diverse. La musica elettronica, da questo punto di vista, è stata consumata dalla tecnologia più rapidamente di quanto non sia avvenuto per la strumentazione acustica. Un suono di violino a volte può sorprenderci molto più di un suono elettronico, che ha una codificazione più veloce e non ha la stessa durata emozionale. E d’altra parte se pensiamo ai musicisti che hanno per primi esplorato lo spazio della musica concreta, ad autori come Pierre Henry o Pierre Schaeffer, ancora oggi sentiamo nella loro opera la freschezza e l’ingenuità della scoperta, sentiamo aprirsi paesaggi sonori che producono ancora un effetto di novità, ci immergono in atmosfere percettive diverse e coinvolgenti più di quelle che sono state capaci di creare, in seguito, la stessa musica concreta e poi la ambient music. Malgrado il tempo trascorso, riconosciamo in quella musica un pensiero, l’individuazione di un campo proiettivo, mentre nella ripetizione di quell’esperienza o nelle sue applicazioni commerciali riconosciamo solo il ritorno del già noto, pronto per una confezione che lo appiattisce. Un compositore come Stockhausen ha individuato un’area sensibile – musicale, non solo poetica e non solo mistica – che lo ha portato a trasformarsi, non a ripetersi: la materia del ciclo Licht è completamente diversa da quella delle sue opere precedenti. Ma, piaccia o non piaccia, lì sentiamo un pensiero che si esercita con il suono. E Luigi Nono: la sua musica fino al Prometeo e dopo il Prometeo è profondamente diversa, negli ultimi quindici anni della sua attività si è continuamente rimesso in discussione confrontandosi con le nuove tecnologie alla ricerca di nuove sonorità che restituissero alla musica una dimensione di incanto.
Catucci – Incanto è una parola ambigua. Si può pensare a un rapimento estatico, a un gioco incantatorio, al trucco di un mago, all’opera di quello che gli antropologi chiamano trickster. Anche di un imbonitore di folle si dice che sa incantare. C’è però un uso diverso della parola che va nella direzione dell’indugio, della sospensione del tempo. È quello a cui si riferisce Hans-Georg Gadamer quando, per descrivere l’incontro con l’opera d’arte, impiega il termine Verweilen, che significa “lasciar essere” e “sostare”, “trattenersi presso”. Mi sembra che sia questo il tipo di incanto al quale guardare: l’indugio di un’esperienza del pensiero opposta come un cuneo alla velocità omologante del consumo.
Battistelli – Sì, non penso al gioco manipolatorio dei suoni. Un gioco che negli anni Ottanta e Novanta si è presentato come una reazione al divieto storico per la ricerca dell’incanto tramite l’enfasi del suono, ma che poi non ha avuto altro sbocco se non quello, appunto, della semplice manipolazione da imbonitori. Ma è così anche per quella musica multietnica che sembra riprodurre più che altro una logica turistica: si prende un catalogo di suoni e di strumenti che vengono giustapposti tramite un medium che li equalizza, per lo più l’elettronica, livellandoli come se provenissero da un unico crogiuolo, un’unica cultura, depotenziandoli, privandoli della possibilità di sorprenderci e di spaesarci. Come in quei viaggi “tutto organizzato” dove non c’è rischio di scoprire qualcosa di imprevisto. La stessa cosa trovo nell’abilità, a volte strabiliante, dei Dj che manipolano con l’elettronica suoni esistenti in una sorta di composizione istantanea che si risolve, però, anche in consumo istantaneo. Non c’è indugio in questo tipo di esperienze sonore. Le musiche realmente significative, invece, sono quelle che richiedono di sostare, che non potrebbero essere ascoltate senza cedere alla necessità dell’indugio. Pensiamo a John Cage o a Franco Donatoni, per rimanere a due autori in programma nella Biennale di quest’anno. Sono autentici monumenti che nessuna esperienza musicale oggi può ignorare e che esigono l’indugio, generano incanto.
Catucci – Questa difesa della musica di ricerca, della musica contemporanea d’arte, può sembrare controcorrente. Ma come, in un’epoca nella quale si discute dell’abbattimento dei confini tra i generi, della legittimazione accademica della musica pop, della nuova musica in mano a ragazzi che non hanno mai messo piede in un conservatorio, Giorgio Battistelli vuole rialzare gli steccati, perimetrare un campo?
Battistelli – Non credo di essere controcorrente. Al contrario. Credo che a introdurre distinzioni, a moltiplicare le linee che attraversano gli orizzonti della musica, sia proprio il nostro presente. Una musica all’altezza dell’attualità non può né riciclare il già noto insistendo su formule standardizzate, né cedere a un atteggiamento autoreferenziale, ma neppure accontentarsi di novità usa e getta. Alla musica, posto che esista un pensiero dotato di questo nome, si richiede mobilità, certo, ma la mobilità della ricerca, non quella di chi è pronto a cambiare prodotto perché ha fiutato un mercato nuovo. E poiché, come dicevo, non ci sono ricette da applicare, e neppure baricentri sui quali fare affidamento, la ricerca deve risolversi in un’invenzione continua e in una continua messa in discussione dei risultati raggiunti. La musica, in questo modo, diviene evento nel senso più forte del termine, e come tale si offre all’esperienza dell’indugio.
Catucci – Citavi il rischio dell’autoreferenzialità. Ma non è proprio questo il rimprovero che si rivolge comunemente a tanta musica contemporanea? Non si dice che questa musica si è allontanata dal pubblico rinchiudendosi in laboratori sperimentali che non comunicano con l’esterno, e a volte neppure con la cerchia degli specialisti? La ricerca, insomma, in musica, non si è un po’ troppo spesso risolta in autoreferenzialità per poter prendere ancora sul serio le sue promesse?
Battistelli – Non bisogna generalizzare. Quando si è chiusa su se stessa, quando è diventata una specie di gioco con le perle di vetro, la musica contemporanea è stata anche lei una forma di manipolazione sonora, sia pure focalizzata su organismi sonori più strutturati. Ma era una musica povera di immaginazione, priva di intuizione, senza visionarietà. Eppure, lo ripeto, non bisogna generalizzare, neppure quando si prende in considerazione il cammino di un solo artista. Prendiamo, per esempio, l’ultima fase creativa di Franco Donatoni, al centro dell’Omaggio che gli sarà dedicato dal Nieuw Ensemble alle Tese delle Vergini il 5 ottobre. Anche attraverso il confronto con la sua malattia, Donatoni è passato dal rischio dell’autoreferenzialità all’autenticità espressiva, come se la sofferenza gli avesse strappato i sistemi di protezione di cui si era dotato e lo avesse lasciato, per così dire, a corpo nudo, costretto a fare affidamento sul proprio intuito. Con esiti musicalmente inattesi e straordinari. E così in Iannis Xenakis, autore al quale Klangforum Wien dedicherà un concerto al Teatro Piccolo Arsenale il 4 ottobre: pur non rinunciando alla musica stocastica, ai suoi calcoli, al suo razionalismo numerico, nelle ultime esperienze compositive è arrivato a occuparsi della musica come evento, come Erlebnis, esperienza vissuta di tipo mitologico ed esistenziale. Il suo è diventato allora un invito all’ascolto del suono in profondità, quasi che avesse smesso di voler oltrepassare la linea, avendo capito che la sua vocazione era piuttosto quella di scavarla a fondo. E a questo livello il suono della musica di Xenakis si esprime con una libertà di cui non era capace quando lo armava di strutture.
Catucci – A proposito di concerti monografici, ce n’è uno di rilievo particolare al Teatro alle Tese il 12 ottobre, dedicato a Luigi Nono, con la presenza di Maurizio Pollini per l’esecuzione di sofferte onde serene…
Battistelli – La presenza di Pollini è importantissima per questa edizione della Biennale Musica, che continua il progetto di esecuzioni di musica di Luigi Nono intrapreso ormai quattro anni fa. Pollini è stato molto legato a Luigi Nono, come artista e come amico, e in particolare è legato a sofferte onde serene…, brano che Nono gli aveva dedicato. Nel concerto del 12 ottobre ci saranno anche La fabbrica illuminata, composizione scritta nello stesso anno di sofferte onde serene…, il 1964, e A floresta é jovem e cheja de vida, terminata nel 1966, oltre a Djamila Boupachà. Ma appunto, prendiamo il caso di Luigi Nono. Pensiamo al coraggio con il quale, a partire dal Prometeo, non ha rinnegato quel che aveva costruito in precedenza, ma l’ha smontato via via ricominciando da capo, costruendo in modo diverso, con materiali e con forme diverse. Un’impresa eccezionale, paragonabile a quella di un architetto che avesse costruito un villaggio ma che, non appena questo si fosse ingrandito fino a diventare una città, tornasse indietro a ricostruirlo strada per strada, senza paura di sporcarsi di nuovo le mani. E pensiamo a un caso totalmente diverso, come quello di John Cage, autore importante non solo per la musica che ha composto, ma anche per quello che ha scritto e per quello che il suo esempio ha provocato, per le novità che ha introdotto nel campo musicale, dall’uso dei dadi e dell’I Ching al pianoforte preparato: l’11 ottobre ne darà un esempio la pianista Margaret Leng Tan in un concerto ai Magazzini del Ferro, mentre il 13 al Piccolo Arsenale ci saranno i 18 Microtonal Ragas per voce, percussioni ed elettronica. Davvero la musica di Cage procede di pari passo con il suo pensiero, è lo strumento del suo pensiero, e la necessità di sostare di fronte alla sua opera si verifica ogni volta che si tocca con mano quanto sia stata importante anche per chi ha scritto in modo completamente diverso da lui.
Catucci - Ben tre concerti saranno dedicati ai compositori italiani delle generazioni più giovani: quattordici autori in tutto, affidati a tre ensembles italiani – Icarus, Divertimento, Algoritmo – fra i più quotati per l’esecuzione di nuova musica. Il titolo che unisce i tre concerti è Made in Italy e i brani sono stati tutti commissionati dalla Biennale, con il sostegno della Compagnia della Musica in Roma, come del resto anche altre due composizioni affidate ad autori più noti come Claudio Ambrosini (Plurimo – per Emilio Vedova, il 13 ottobre) e Michele dall’Ongaro (Avatar, 12 ottobre). Com’è stata condotta la scelta degli autori?
Battistelli – Anche negli anni scorsi quando ho coinvolto autori italiani più giovani, non importa se esordienti o già in carriera, ho cercato di individuare quelli dalla cui opera proviene un senso di necessità totalmente opposto al gusto della manipolazione sonora. Autori diversi, a volte discutibili, ma l’intento non era quello di formare una squadra, di consolidare una tendenza, ma di riflettere come in uno specchio nuove esperienze di ricerca e di creatività musicale. Credo che questo sia uno dei compiti fondamentali di un festival come la Biennale Musica. Oggi abbiamo voluto dare vita a una sorta Padiglione Italia chiamando musicisti che non siano solo affascinati dall’elemento tecnico, ma che perseguano con la loro musica una ricerca di senso, affidando la loro musica a gruppi di qualità e a direttori esperti come Marco Angius, Erasmo Gaudiomonte e Sandro Gorli.
Catucci – Mi pare di capire che anche una certa presa di distanza nei confronti della tecnica rappresenti un filo rosso di questa Biennale.
Battistelli – Non presa di distanza dalla tecnica, ma dalla nevrosi ipertecnologica che si manifesta in due modi distinti eppure collegati fra loro: desiderio di acquisire un’abilità tecnica di costruzione dell’organismo sonoro che sconfina con la manipolazione e desiderio di essere al passo con le innovazioni degli strumenti tecnologici. Questa nevrosi finisce per accumulare così tanti materiali da forzare il perimetro dei campi proiettivi già esistenti, già sfruttati, mentre il problema dell’arte consiste nell’individuarli, i campi proiettivi, e nell’imparare a muovercisi dentro. La tecnica e la tecnologia non possono, di per sé, legittimare l’operazione artistica. Anche perché l’adozione di una tecnica o di uno strumento nuovo non ha in sé niente di trasgressivo, non aiuta a oltrepassare la linea. Un potenziale trasgressivo può averlo un cluster e può averlo un accordo di do maggiore, dipende da come si usa. Non c’è una soluzione linguistica o teorica in sé più innovativa. La difficoltà è creare una forma, un contesto tale per cui può diventare trasgressivo anche un suono storicamente codificato, che porta con sé secoli di cristallizzazione. Del resto anche il cluster, ormai, ha la sua sedimentazione semantica.
Catucci – A proposito di stratificazioni storiche, bisognerebbe affrontare il problema degli organici strumentali. Perché gli strumenti acustici, il quartetto per archi, l’orchestra sinfonica e la forma più agile della sinfonietta, cellula base di cinque legni e cinque archi, dovrebbero essere ancora un mezzo di espressione attuale per i musicisti più giovani?
Battistelli – L’orchestra, diceva Fedele d’Amico, non è una cosa che si trova in natura, ma è il prodotto di una lunga opera di selezione e di combinazione che nel tempo si è rivelata luogo di sperimentazione e di ricerca, senza perdere di efficacia neppure con la comparsa di strumenti e di suoni nuovi, che a volte sono stati incorporati nell’orchestra in modo sistematico oppure solo occasionale. L’orchestra, gli strumenti acustici, portano senz’altro con sé un deposito di memoria, di passato, ma possiedono anche un’elasticità d’uso e un’apertura di senso che li rendono tuttora i referenti privilegiati del pensiero musicale. Direi anzi che proprio nel contatto con questi strumenti la creatività musicale rivela di avere, nel profondo, una natura alchemica. E che proprio da questi strumenti proviene un invito alla decelerazione che facilita l’indugio. Del resto la ricerca di suoni nuovi non può essere l’elemento trainante della ricerca musicale. In parte è stato così nel Novecento, ma si tratta ormai di un’esperienza anch’essa storicizzata. Escludere gli strumenti tradizionali, oppure traumatizzarli infilandoci viti, pezzi di vetro, usandoli in modo improprio, è stato un passaggio che ha permesso di uscire dagli stereotipi, che ci ha fatto scoprire nuovi modi di forzare l’orchestra per trasformarla o per distruggerla, come già faceva Olivier Messiaen e come ha fatto, a modo suo, Stockhausen. Ma è una fase superata. Oggi anche quegli espedienti un tempo trasgressivi fanno parte di un uso storico degli strumenti tradizionali. E allora l’orchestra si presta a ulteriori forme di sperimentazione che prediligono, per esempio, organici insoliti, atipici, come avviene per esempio nella musica di Wolfgang Rihm o in quella di György Kurtág, le cui orchestre spesso hanno ben poco di assimilabile a modelli storicamente consolidati. Io credo fermamente nell’attualità degli strumenti acustici e dell’orchestra nelle sue varie tipologie e dimensioni, oltre che nella possibilità di innesti che la trasformano sensibilmente. Per questo vorrei sottolineare la presenza di tre orchestre importanti nel cartellone di questa Biennale – l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Orchestra dell’Arena di Verona -, così come vorrei mettere in evidenza l’appuntamento del 13 ottobre al Teatro alle Tese, quando tre compositori si confronteranno con la forma apparentemente classica e cristallizzata del concerto per strumento solista, ma partendo ciascuno da luoghi e storie diverse, utilizzando strumenti che fanno riferimento a memorie musicali differenti. Claudio Ambrosini proporrà un Concerto per due pianoforti e orchestra, Plurimo (per Emilo Vedova). Il cinese Guo Wenjing una composizione per ehru, il violino cinese, e orchestra. L’australiana Liza Lim un Concerto per digeridoo, flauto e orchestra.
Catucci – In che cosa questi innesti di strumenti etnici nell’orchestra sono diversi dal multiculturalismo che prima avevi definito “turistico”?
Battistelli – In tutto. Toru Takemitsu aveva riflettuto sul suo rapporto con la tradizione giapponese, dalla quale proveniva, e con la forma della musica colta occidentale, nella quale si era formato, parlando della possibilità di ospitare una memoria nell’altra. Ospitare vuol dire però non solo accogliere, ma mettersi a disposizione di chi arriva e cercare di farlo sentire a casa propria. È il contrario di una forma di omologazione che in realtà non ospita ma assimila, non accoglie ma incasella. Per questo l’impiego di uno strumento australiano o cinese accanto all’orchestra sinfonica vuole creare le condizioni di un dialogo, non di un monologo colorato di elettronica e di cultura locale. In lavori come quelli di Liza Lim o di Guo Wenjing, si assiste a un’opera di decontestualizzazione dello strumento etnico, di destrutturazione della forma-concerto, infine di ricostruzione di questa stessa forma a partire dal contributo offerto dal digeridoo o dall’ehru. E un’operazione di tipo analogo si ritrova anche nella musica di autori cinesi, giapponesi, coreani, kuwatiani, giordani e israeliani che verrà eseguita dal Nieuw Ensemble il 6 ottobre alle Tese delle Vergini. Al contrario, nella musica da pacchetto turistico c’è da un lato la frantumazione del materiale originario, dall’altro il ricorso a modalità di accostamento che sono subito riconoscibili per una collettività: la mediazione dell’elettronica, l’amplificazione degli strumenti, la pulsazione ritmica come collante.
Catucci – Michael Nyman, che il giorno dell’inaugurazione, il 4 ottobre, presenta al Teatro alle Tese Sonetti Lussuriosi, una nuova opera commissionata dalla Biennale Musica, è però un maestro della pulsazione ritmica iterativa, ipnotica. Come si spiega la sua presenza in cartellone?
Battistelli – Il nome di Nyman è legato a un altro filone che ho cercato di seguire in questi anni di lavoro alla Biennale Musica: alla linea nella quale la musica si relaziona con l’immagine, sia con quella prodotta tecnicamente sia con quella del teatro e della scena. L’edizione di tre anni fa si intitolava proprio per questo La musica e il suo doppio. Ma anche quest’anno la relazione con la dimensione visiva, scenica o virtuale non importa, trova occasioni di sperimentazione per esempio con Zeugen, di Georges Aperghis, opera per marionette, soprano, attore, piccolo ensemble e proiezioni video che debutterà il 6 ottobre ai Magazzini del Ferro, nella nuova musica che l’argentino Martin Matalon ha scritto e dirigerà il 9 ottobre, al Teatro Piccolo Arsenale, per un classico sempre vivo come Metropolis di Fritz Lang, o anche nel concerto che il Klangforum Wien dedicherà ai Free Radicals il 10 ottobre, al Teatro alle Tese. Per tornare a Nyman: tutti sanno che ha lavorato molto per il cinema, e non solo con Peter Greenaway, ma pochi sanno invece che è lui stesso un fotografo e un videomaker appassionato. Quel che gli ho chiesto è stato di scrivere una musica pensata non per immagini girate da altri, ma per l’universo visivo che lui stesso ha accumulato nel corso degli anni, come piazzando all’interno della costruzione sonora il suo stesso occhio, il suo stesso sguardo sull’immagine. È un modo di andare “oltre la linea” della musica applicata al visivo come colonna sonora, ma anche di superare il limite tradizionale del concerto. Ed è per questo che, malgrado la riconoscibilità stilistica della musica di Nyman, con quella sua iteratività “colta” intesa come risposta europea ai modelli americani, si tratta di un’operazione nuova, nella quale il riferimento all’immagine gioca un ruolo centrale ed è tutto nelle mani del musicista.
Catucci – Scorrendo il calendario degli appuntamenti di questa Biennale Musica trovo altri appuntamenti su cui occorrerebbe soffermarsi. Dagli omaggi monografici a compositori come Mauricio Kagel e Francesco Pennisi (11 e 13 ottobre, sempre al Teatro Piccolo Arsenale), alla presenza assidua di gruppi prestigiosi come MusikFabrik, Nieuw Ensemble, Ensemble Recherche, Klangforum Wien, quest’ultimo protagonista di un concerto (8 ottobre, Tese delle Vergini) nel quale verrà eseguita una composizione di Friedrich Cehra (premiato con il Leone d’Oro lo scorso anno), ma poi anche al centro di una Masterclass per compositori e strumentisti che si terrà al Conservatorio di Venezia. Volendo però individuare il centro strategico di questa edizione, e forse anche l’appuntamento che più di altri ha suggerito il titolo Oltre la linea, mi viene da pensare sempre al Klangforum Wien, al concerto che abbiamo già citato e che si intitola Free Radicals (10 ottobre).
Battistelli- Non so se sia il centro, ma senz’altro è uno dei momenti cruciali della Biennale 2007. In programma ci sono quindici autori, da Schoenberg a Berio, da Xenakis a Birtwistle e Stockhausen, da Beat Furrer a David Horne, come dire ricercatori “radicali” che attraversano più generazioni e che vengono messi a confronto, ancora una volta, con il tema dell’immagine. A ogni brano sarà associato, infatti, un “corto” appositamente realizzato e su cui sono intervenuti anche i musicisti del Klangforum Wien, a cominciare dal direttore Furrer. L’idea è che né il suono né l’immagine si associno l’uno all’altra come se fossero due universi indipendenti, ciascuno compiuto in sé, ma che prendano forma incontrandosi, magari anche scontrandosi, ma sempre approfondendo la linea della loro possibile relazione fino a esplorarne possibilità inedite, eventualmente per oltrepassarla. Credo che l’integrazione dell’immagine nel lavoro del compositore sia appunto una delle linee sulle quali si gioca, oggi, la possibilità non solo di ascoltare, ma anche di “vedere” la musica.
Catucci – Citando il nome di Cehra, poco fa, abbiamo accennato al Leone d’Oro, anzi ai due Leoni – uno alla Carriera e l’altro alla Musica del Presente – che l’anno scorso sono stati introdotti proprio per sottolineare il rapporto della Biennale con la nuova musica: un rapporto di riconoscimento, di esplorazione e di promozione.
Battistelli – Sì, è una novità che spero rimanga anche in futuro, perché la musica contemporanea d’arte ha bisogno di una vetrina internazionale che le dia maggiore visibilità e che segnali, nel panorama così frastagliato del presente, quali esperienze rappresentino punti di riferimento obbligati. E come la Biennale Musica è per vocazione un osservatorio sul presente, e non la presa di posizione in favore di una sola linea, di una sola tendenza, così il Leone d’Oro è un premio che non riflette una sola visione del presente, ma attribuisce visibilità a percorsi e ricerche potenzialmente distanti fra loro, contribuendo a definire il ruolo che occupano e svolgono nella dimensione dell’attualità musicale. Il Leone d’Oro alla Carriera assegnato l’anno scorso a Friedrich Cehra, e quello per la Musica del Presente che è andato a Beat Furrer, sono precisi esempi di un premio che può permettersi di non seguire la corrente dei media perché è dotato di un suo prestigio e di una propria forza mediatica.
Catucci – Il Leone d’Oro alla Carriera di quest’anno è stato già annunciato e sarà assegnato a Giacomo Manzoni, con quale motivazione?
Battistelli – Manzoni è un autore le cui opere hanno profondamente segnato la contemporaneità, ma la cui attività va oltre quella del compositore. Manzoni è un intellettuale della musica, basti pensare che ha introdotto in Italia, con traduzioni pregevoli, opere come la Filosofia della musica moderna di Adorno e il Manuale di armonia di Schoenberg. Inoltre è stato un maestro molto importante per generazioni di musicisti, ma che non ha mai prodotto una “scuola” nel senso stretto del termine. Voglio dire che non ha né imposto né favorito il perpetuarsi di una sola linea estetica e compositiva, ma ha dato ai suoi allievi una lezione di rigore e di libertà, tanto che molti di loro hanno seguito strade diversissime dalla sua. Nella sua musica non ha mai smesso di interrogarsi, di rimettersi in discussione, senza accomodarsi in una ricetta da ripetere all’infinito. E credo che questo atteggiamento sperimentale, questo bisogno di trasformarsi, siano alla base dell’impressione di libertà che deriva non solo dal suo insegnamento, ma anche, a saperla ascoltare, dalla sua opera. L’occasione per farlo è l’esecuzione di una sua opera giovanile, La legge, un lavoro del 1955 mai presentato prima, e interessante proprio per il modo in cui Manzoni pensa il rapporto fra musica e drammaturgia.
Catucci – Il titolo Oltre la linea mi riporta anche al fatto che, all’epoca del tuo lavoro sull’opera Auf den Marmorklippen, hai avuto scambi diretti con Ernst Jünger. Che rapporto aveva con la musica?
Battistelli – Fin dai primi contatti epistolari Jünger mi confessò di non avere grandi rapporti con la musica, ed era meravigliato che qualcuno pensasse di scrivere un’opera partendo da un suo testo. Quando andai a trovarlo nella sua casa di Wilflingen fu ancora più esplicito al riguardo. La casa, in particolare la sua camera, avevano un aspetto monacale, spoglio, e Jünger volle che io ascoltassi il silenzio in cui il tutto era immerso, confessandomi che il rumore prodotto dal legno centenario del pavimento o dei tetti, o quello del vento attraverso le finestre, erano l’unica musica alla quale egli prestasse orecchio. Non posso dire di non esserne rimasto sorpreso. Che Jünger non fosse interessato alla musica non impedì, comunque, che egli si sentisse via via sempre più coinvolto dal progetto.
Catucci – Auf den Marmorklippen fu eseguita per la prima volta tre anni dopo la sua morte, nel 2001. Era ancora vivo, però, quando venne eseguita un’altra partitura che gli hai dedicato, Anarca, un lavoro per orchestra. Ha avuto modo di ascoltarlo?
Battistelli – Sì, ne ascoltò una registrazione, e mi scrisse di essere rimasto molto colpito da una musica che definì più o meno come un «viaggio» sorprendentemente «pieno di colori».
Catucci – Perché hai scelto Anarca, una figura che Jünger tratteggia soprattutto nel romanzo Eumeswil e che incarna, appunto, l’idea di una resistenza in fondo anarchica?
Battistelli – L’anarca è, per Jünger, profondamente diverso dal rivoluzionario che combatte il monarca essenzialmente per sostituirsi a lui, per prenderne il potere. L’anarca sa che può uccidere il monarca quando vuole, ma non lo fa. Non gli interessa farlo. Per l’anarca è più importante la potenzialità, l’apertura verso possibilità che verrebbero tradite, irrigidite, e inevitabilmente ideologizzate, qualora venissero espresse in maniera diretta. Per Jünger credo fosse anche una risposta a chi gli chiedeva perché non fosse rivoluzionario nella sua scrittura. Per me è l’idea che lega appunto la rivoluzione alla potenzialità: non si può essere rivoluzionari come per una coazione a ripetere, ma non si può neppure agire come se la rivoluzione non fosse possibile. Nell’arte, e nella musica, bisogna sempre aver presente la potenzialità del gesto rivoluzionario, e anche il rinunciarvi, il non farlo, dev’essere inscritto in questa potenzialità. Quando non è così, ci si limita a ratificare il presente, si ripetono formule già sperimentate e consumate. Ma se il nome “arte” ha ancora un senso, credo che stia tutto dalla parte dell’anarca.
-
Tre conversazioni con il filosofo Stefano Catucci
Pensare la musica, ancora
Stefano Catucci – Il titolo di questa nuova edizione della Biennale Musica, Va pensiero, gioca su una citazione popolarissima per indicare un tema tutt’altro che scontato: riavvicinare la musica al pensiero, ovvero far sì che il pensiero – quello filosofico ed estetico in primo luogo – torni a occuparsi di musica, arte che negli ultimi vent’anni sembra essere vissuta “al riparo” dal pensiero, come se avesse voluto liberarsi da un impaccio. Vorrei chiederti anzitutto se trovi una linea di continuità fra questa esigenza di tornare a pensare la musica – a farla pensare, anche – e quel che è accaduto nelle edizioni precedenti da te dirette.
Giorgio Battistelli – La prima edizione che ho diretto, due anni fa, si intitolava Venezia, la musica e il mondo, e aveva lo scopo di far leva sulla qualità unica di Venezia come torre d’avvistamento planetaria per gettare uno sguardo su ciò che rende oggi particolarmente inquieto il panorama delle pratiche musicali: non si trattava, perciò, di un’osservazione neutrale, ma di uno sguardo rivolto ai turbamenti che la musica sta vivendo. L’anno scorso l’edizione intitolata La musica e il suo doppio metteva in questione i rapporti fra musica e tecnica, musica e scena, musica e parola, dunque non uno, ma una serie di “doppi” che per la musica rappresentano altrettante occasioni di pensiero. Credo siano state due tappe di avvicinamento a un problema che ora ho cercato di porre in maniera più esplicita, anzi nel più esplicito possibile dei modi, nella convinzione che il compito di pensare la musica oggi, come recita il titolo di un vecchio libro di Pierre Boulez, sia diventato più urgente che mai.
Catucci – Ma quando Boulez scriveva quel libro, al principio degli anni Settanta, la musica non soffriva forse di un eccesso di pensiero, spinto fino all’ideologizzazione di un’estetica?
Battistelli – Nei miei quaderni di appunti ho segnato una frase di Carmelo Bene, presa da una sua intervista: «la musica contemporanea è molto pensata, anzi pensosissima, strapiena di cavilli, di pensieri, c’è troppa oggettività». Credo che la musica di quegli anni fosse così preoccupata dalla cancellazione del soggetto da aver perduto uno dei suoi campi proiettivi fondamentali, con parole non mie lo chiamerei la dimensione dell’incanto. È un’intuizione di Massimo Cacciari che ho annotato nello stesso taccuino: «dal momento in cui ci siamo allontananti da una dimensione di incanto rispetto al suono, il nostro orecchio si è rivolto all’ascolto dell’immagine». Credo che il bisogno di pensare la musica, oggi, si collochi al livello di questo cambiamento, di ciò che porta con sé e che è rimasto ancora impensato, di quell’eccesso di oggettività dal quale la musica sembra aver preso le distanze, ma correndo il rischio di cadere in un eccesso opposto, quello dell’ingenuità.
Catucci – La scelta di un titolo popolare come Va pensiero mi ha fatto pensare a una conversazione di tanti anni fa con Giuseppe Sinopoli. Raccontava della sua scoperta di Verdi, e in particolare proprio del Nabucco, nel periodo nel quale aveva abbandonato la composizione, dopo la sua Lou Salome, e si sentiva annaspare nell’incertezza. Dopo anni dedicati a una musica nella quale il segno era studiatissimo, calcolato al millesimo, rinunciando alla resa emotiva del suono – all’incanto, se vogliamo -, ecco l’incontro con un autore che del segno si cura pochissimo, ma che da soluzioni strutturalmente elementari è capace di trarre una potenza emotiva altissima. «Verdi è questo: arte povera», disse, e dava a intendere che quell’incontro aveva avuto per lui il senso di una liberazione.
Battistelli – È una delle strade possibili, e del resto è stata percorsa non solo dal minimalismo americano, nella via che va da La Monte Young a John Adams, ma anche da autori dell’Oriente europeo come Gya Kancheli, Arvo Pärt etc. L’importanza di questi tentativi io la vedo nel desiderio di riabilitare l’ascolto dell’esperienza, senza limitarsi all’oggettività nella manipolazione del materiale musicale. Quando ci si concentra troppo sul materiale si toglie valore all’ascolto dell’esperienza, che d’altra parte comporta anche la discesa in un registro retorico e chiede che si nutra, e si ascolti, anche un sentimento. È come se si fosse voluto opporre un tipo di intelligenza musicale più immediata, “naturale”, a una più pensata, più ragionata, ma che non per questo è automaticamente più importante.
Catucci – Ed è per questo che la musica ha cercato di “liberarsi” dal pensiero, come dicevo prima. Dagli anni Settanta, oltretutto, la tecnica ha avuto sviluppi straordinari: l’elaborazione elettronica del suono non è più appannagio di pochi centri di ricerca istituzionali, ma è accessibile potenzialmente a tutti con un buon Pc, e il parametro del “controllo” esercitato sul materiale, considerato un tempo il discrimine fra composizione ingenua e rigorosa, è affidato quasi più alla competenza informatica che non al bagaglio della preparazione accademica. In questo ambito sembra realistica una vecchia profezia di Brian Eno, quella secondo cui gran parte della produzione musicale più avanzata diventerà opera di non-musicisti, cioè di artisti privi di preparazione classica e spesso incapaci anche di leggere il pentagramma.
Battistelli- In parte è una profezia già avverata. Basti pensare ai procedimenti di giustapposizione con cui lavorano i Dj. Si frantumano e segmentano dei materiali preesistenti fino ad atomizzarli e poi a riunirli intorno a dei centri di condensazione molto riconoscibili, nei quali precipita anche un’energia collettiva: ritmi ostinati, pulsanti, esposizioni e cambiamenti timbrici che ritroviamo anche al cinema o in televisione, ma resi più astratti. La loro è una tecnica di montaggio più vicina a quella del materiale visivo che non alla composizione classica, nella quale la relazione fra ciò che precede e ciò che segue, fra antecedente e conseguente, è sempre centrale. In queste nuove tecniche non si è condizionati in alcun modo dalla storia del materiale, anzi questa storia viene neutralizzata persino in quella dimensione minima che riguarda il suo decorso all’interno di un singolo brano. I materiali, allora, diventano tutti omogenei: si può prendere una scheggia di canzone rock o di una Sinfonia di Mahler, come pure il rumore di un vetro che si rompe – è un esempio intensivo di globalizzazione.
Catucci – Eppure un attento osservatore dell’avanguardia storica, Luigi Rognoni, di fronte ai primi esperimenti di musica elettroacustica vedeva aprirsi la possibilità di un ritorno verso la “natura” del suono contro le mediazioni e gli artifici di un sistema armonico come quello occidentale, temperato, che in fondo anche la dodecafonia aveva lasciato intatto. Cito (Rognoni scrive nel 1966): «l’aspetto più importante, la cui portata è impossibile valutare oggi in tutte le sue conseguenze, risiede nel profondo significato umano che va acquistando l’esperienza della musica elettronica; la quale si presenta oggi non tanto e ancora come un mero problema artistico, quanto come una via aperta verso un insperato “ritorno alla natura” del linguaggio dei suoni che consenta all’uomo di ritrovare veramente se stesso». L’equivalenza tra il suono di uno strumento musicale e quello campionato “dal vero” non è un passo in questa direzione?
Battistelli – Anche quel che diceva Rognoni in parte si è avverato, ma proprio per questo io credo che non l’incontro con la “natura” del suono, ma la ricerca di una sua nuova dimensione di incanto sia il problema che la musica deve porsi, se pensiamo ancora alla musica come a un’arte. Rispetto al passato, quindi, non è più questione di trasgredire, di passare il limite, ma individuare i campi proiettivi nei quali l’incanto è ancora possibile, o lo è di nuovo. Il nostro spazio musicale è oggi saturo di materia proveniente da ogni angolo della storia e della geografia: abbiamo accesso a un repertorio immenso, possiamo ascoltare nello stesso giorno un canto siberiano, un mottetto fiammingo, un’aria d’opera di un minore settecentesco, una registrazione rara di Miles Davis, un pezzo rock e un movimento di una sinfonia di Bruckner. I suoni innovativi vengono più spesso dalla sperimentazione elettronica dei Dj o dal rock che dalle ricerche dell’Ircam di Parigi. Ma questo significa solo che l’elemento tecnologico e l’invenzione di un suono non garantiscono più nulla al livello dell’innovazione musicale in senso proprio. Il problema è piuttosto come inventare una forma capace di rispondere a una materia così sovrabbondante, è come articolare un pensiero. Fino a cinquant’anni fa la musica si concepiva ancora in un asse diacronico, per cui contava confrontarsi con il passato e saper ricostruire la genealogia del proprio linguaggio. Oggi domina la verticalità dell’ascolto, c’è totale compresenza, dai neumi in campo aperto alla techno.
Catucci – In musica questo è particolarmente evidente, ma è un fenomeno che va al di là della musica: una concentrazione sul presente che ha come corollari non solo il rifiuto del passato, ma anche la difficoltà di immaginare il futuro.
Battistelli – Non riguarda solo la musica, certo. Ma insisto sulla parola “arte”: se la musica vuole e può ancora pensarsi in questo modo, credo non debba riflettere su di sé in termini di funzione sociale, di tecnica o di scrittura, ma in primo luogo come relazione con l’ascolto.
Catucci – Dall’esigenza di riaprire il confronto tra la musica e il pensiero mi pare venga anche il bisogno di una nuova estetica musicale ancora tutta da scrivere. Qualche contributo comincia a emergere, negli ultimi anni, in questa direzione, anche se in modo sparso. E quel che vedo profilarsi all’orizzonte è un ritorno alla nozione di “autonomia” della musica come arte: autonomia dal mercato, dal mainstream, dal già-sentito, ma soprattutto autonomia etica, non solo estetica, se si vede la musica come una possibilità di costruire se stessi. Per usare il linguaggio dell’ultimo Foucault, la musica andrebbe intesa quasi come una “tecnologia del sé”, ma di un “sé” allargato che, tramite l’ascolto, diviene subito collettività, comunità.
Battistelli – Quello dell’autonomia è un principio importante, anche se il sistema produttivo oggi tende a ridurre al minimo gli spazi di autonomia possibile. Autonomia, credo, è però anche la capacità di dare forma sonora a un’immaginazione condivisa ma che, senza quella forma, senza quella musica, non percepiremmo affatto. Ovvero la capacità di cogliere quei campi proiettivi nei quali le forme dell’immaginario prendono le sembianze del suono.
Catucci – Vogliamo vedere in concreto come queste parole si riflettono sul programma della Biennale Musica di quest’anno?
Battistelli – Il programma di quest’anno segue essenzialmente due linee. Una rivolta all’esplorazione delle pratiche musicali contemporanee, l’altra alla messa in questione dell’esperienza dell’ascolto. Un osservatorio e un laboratorio, insomma, come la vocazione storica della Biennale Musica richiede. Chiaro che la relazione fra musica e pensiero è maggiormente in primo piano quando si tratta di tematizzare l’ascolto. Penso all’installazione di Brian Eno che verrà allestita allo Spazio Cisterne dell’Arsenale e che accompagnerà tutta la durata della Biennale Musica: qui il mezzo tecnologico diventa strutturante e definisce uno spazio sonoro dove la dimensione percettiva sarà diversa da quella di un normale concerto. Anche la serata di inaugurazione, con Symposion, va letta in questa direzione: una maratona di sette ore, con musiche del repertorio novecentesco diventate ormai classiche, da Mahler al Terry Riley di In C, fino a prime esecuzioni assolute di nuove composizioni. Un concerto anomalo, affidato al Klangforum Wien, durante la quale si mangerà, si berrà, verranno lette riflessioni filosofiche, il tutto con l’idea di far percepire non solo il contenuto, la musica, ma anche la cornice, così da far emergere in primo piano il gioco delle condizioni in cui si ascolta. Un’alterazione ancora più plateale sarà poi quella proposta da Michel Redolfi alla Piscina di sant’Alvise, dato che i musicisti suoneranno immersi nell’acqua e per ascoltare il pubblico dovrà immergersi a sua volta, tenendo sott’acqua almeno la testa. La vibrazione dell’onda sonora passerà non attraverso l’aria, ma appunto attraverso l’acqua. Ma al di là della singola performance, l’idea è quella di individuare le zone di crisi nelle quali la musica contemporanea si confronta con la dimensione dell’ascolto. Anche coinvolgere un gruppo di rango come l’Ensemble Modern in una serata di improvvisazione con musicisti indiani è un modo di giocare con i perturbamenti dell’ascolto, e così sarà con Bob Ashley, autore americano del dopo-Cage che mescola musica elettronica e parola, anche a più voci, dando l’impressione di essere stato un geniale anticipatore della musica rap, oggi riscoperto in questo senso dallle giovani generazioni.
Catucci – Anche quest’anno verrà proposta una composizione poco nota di Luigi Nono.
Battistelli – Sì, Fucik Project. Sarà la prima esecuzione italiana, la prima assoluta essendo stata fissata a inizio maggio 2006 alla Biennale di Monaco di Baviera. Ma oltre al lavoro su Nono, che rappresenta ormai una costante della Biennale, vorrei sottolineare la volontà di rilanciare la sua apertura internazionale, di fare cioè della Biennale Musica un partner ideativo e produttivo coinvolto alla pari con altre istituzioni di prestigio, e non solo in Europa. La presenza dell’Ensemble Klangforum come gruppo musicale “in residence” è significativa, da questo punto di vista, non solo perché si tratta di una delle formazioni migliori al mondo nel campo della musica contemporanea, ma anche perché ognuno dei tre progetti nei quali è coinvolto – Symposion, Fama di Beat Furrer e un concerto con musiche di Helmut Lachenmann e Georges Aperghis – è stato pensato per Venezia, e il lavoro di preparazione è stato così coinvolgente che abbiamo chiesto ai musicisti di Klangforum di tenere una giornata di studi per compositori e interpreti strumentisti al Conservatorio di Venezia sulle tecniche interpretative ed esecutive inerenti alla scrittura musicale contemporanea.
Catucci – L’apertura internazionale si riflette anche nel sistema delle coproduzioni con altri Festival, un aspetto che nell’edizione di quest’anno mi sembra diventato addirittura sistematico.
Battistelli – Coprodurre non è solo una maniera di ripartire i costi di un progetto, di una commissione, di un allestimento, ma è soprattutto un modo per proiettare l’esperienza di un Festival oltre i suoi limiti geografici e di calendario, rendendo il suo programma parte di una macchina molto più estesa e ramificata. Che la Biennale Musica torni a essere il fulcro di un sistema di coproduzioni significa immaginarla come un centro d’irradiazione di nuove idee e nuove iniziative non destinate a esaurirsi nell’arco di una sola manifestazione, o in un’area di circolazione solo italiana, ma da comprendere in orizzonti più vasti. Quest’anno abbiamo stabilito rapporti di coproduzione con molte istituzioni e gruppi: da Musicadhoy di Madrid al Festival di Città del Messico, dal Festival d’Automne di Parigi al Berliner Festspiele, dal Musik der Jahrhunderte di Stuttgart al Teatro Español di Madrid, da MusikFabrik di Colonia alla Kunststiftung NRW,
per citarne alcuni. Ma soprattutto ci tengo a sottolineare la preziosa collaborazione e intesa culturale con il Teatro La Fenice, un rapporto che si sta sviluppando in maniera proficua e che si pone come una rarità nel panorama musicale italiano. Queste collaborazioni hanno reso possibile la creazione di Brian Eno su nostra richiesta di una installazione sonora allo Spazio Cisterne dell’Arsenale, alle commissioni di una nuova composizione a Wolfgang Rihm, Vigilia, o la realizzazione di Fama, di Beat Furrer, e di Murmullos del páramo del messicano Julio Estrada, o ancora le commissioni che abbiamo dato come Biennale a compositori come Giacomo Manzoni, Valerio Sannicandro, Adriano Guarnieri, Xavier Torres Maldonado, Massimo Botter e per finire le numerose composizioni in prima esecuzione italiana. Pensare la musica, pensarla in concreto, non significa solo porsi questioni di ordine estetico o filosofico, ma anche rispondere a precisi problemi di relazione con il mercato, con gli scambi internazionali, con i limiti di ricezione tipici della musica contemporanea di ricerca. Per rispondere anche a una domanda di tipo organizzativo, pratico, un Festival come la Biennale deve però proiettarsi oltre i suoi confini naturali e farsi “pensante”. Deve immaginare la musica nelle sue forme e nelle sue possibilità di esecuzione. Deve coinvolgere energie e liberarle dando loro lo spazio di cui hanno bisogno. Deve tentare di farsi soggetto produttivo e nodo di una rete di scambi. Venezia, da questo punto di vista, offre opportunità uniche. Non coglierne le potenzialità sarebbe come commettere un delitto contro la musica: contro il suo possibile futuro.
-
Lo spunto dai Madrigali guerrieri e amorosi
Inventis facile est addere
La musica di Monteverdi dalla quale ho preso spunto proviene dai Madrigali guerrieri e amorosi, dunque dal Libro VIII dei Madrigali, e dai Vespri della Beata Vergine. Dalla fine del Libro VIII ho tratto anche il titolo Inventis facile est addere. Queste parole, scritte proprio da Monteverdi, mi sono sembrate l’indicazione di un compito e di una sfida. Inventare aggiungendosi al lavoro altrui, variando o magari distorcendo il lavoro altrui, non è necessariamente più facile in un’epoca come la nostra, nella quale tutto lo spettro di possibilità che va dall’interpretazione al tradimento, dalla citazione alla dissimulazione, è stato ampiamente battuto e ribattuto. Da quelle parole di Monteverdi ho voluto prendere spunto per compiere un viaggio diverso: non partire dal mio linguaggio per trasformare quello di Monteverdi, ma imparare dalla sua lingua per modificare la mia.
Vanamente, dunque, si cercherebbero qui delle citazioni: ce ne sono, si possono riconoscere volendo piccoli frammenti sparsi, in particolare dai Vespri. L’ambito della citazione, però, non è quello in cui ho voluto portare la sfida che proveniva da Monteverdi. Dalla sua musica ho cercato semmai di riprendere la dimensione materiale e gestuale. L’aspetto performativo e teatrale, rappresentativo, prevale perciò sul gioco del reperimento di singole somiglianze. Sin da quando ho lavorato sul Combattimento di Tancredi e Clorinda, nel 2005, avevo capito del resto che la ricerca di affinità e somiglianze non è il modo giusto per lavorare non tanto su Monteverdi, ma con lui. La musica di Monteverdi mette in gioco strategie di elusione più che di riconoscimento, di travestimento più che di identificazione, di equivoco più che di comprensione. Di qui l’idea di accogliere la funzione costruttiva da lui assegnata ai ritmi, alle dinamiche, ai timbri, e di comporre una musica il più possibile libera dal rovello mentale della profondità e dell’interiorità, esonerata dalla psicologia e dal romanticismo. Sappiamo quanto Nietzsche fosse diffidente nei confronti della profondità e raccomandasse, semmai, la superficie. Risalendo alle origini della lingua musicale moderna riconosciamo in Monteverdi un filosofo della maschera e dell’apparenza e desideriamo leggerlo con gli occhi di Nietzsche, un po’ come Borges ha voluto fare con il Don Chisciotte seguendo il lavoro immaginario di Pierre Menard. Leggendo Monteverdi in questo modo troviamo in lui, oggi, quella che Luciano Berio definiva «la complessità della semplicità». L’ornamentazione, le fioriture, la prevalenza di uno sviluppo orizzontale rispetto al dominio della verticalità, dimensione più adatta allo scavo del mondo interiore, è ciò che riflette nella composizione una convinzione insieme rinascimentale e contemporanea: quella per cui la profondità può essere un inganno.
Avendo voluto lavorare sulla materia e sul gesto della musica di Monteverdi, non si troverà in questa mia nuova composizione la voce, non si troverà il canto. Solo in chiusura dall’impasto dell’orchestra emergerà un suono vocale, sia pure in maschera, cioè campionato. Una sola nota, un Re, che si estende solo su quattro battute sopra una dissolvenza incrociata degli archi subito prima che la musica si spenga nel silenzio, per evocare con quell’unica nota la memoria di una voce ridotta a gesto sonoro e non, come pure avviene nella musica di Monteverdi, a ingrediente drammatico ed espressivo. Proprio la memoria è l’altro aspetto su cui gioca una composizione basata su elementi ricorrenti, ostinati come possono esserlo alcune figure ritmiche inventate da Monteverdi e da lui donate al futuro della musica perché questa potesse aggiungervi invenzioni ulteriori, non necessariamente più facili. Intensificazioni della dinamica e del movimento si alternano, qui, a momenti di sospensione, sfere di suono più rarefatto nelle quali tutta l’agitazione precedente si disperde come in uno stato gassoso subito prima di tornare a farsi solida e di ricominciare il suo corso. Alcune anomalie timbriche incidono alcuni tagli nel tessuto sonoro come se un altro gesto, preso dall’arte figurativa del Novecento, collaborasse con le fioriture monteverdiane e fare della musica un luogo di rammemorazione e di pensiero. Compare per esempio il pianoforte. Compare l’arpa, ma la campionatura elettronica le permette di realizzare suoni che l’arpa diatonica non può emettere, una scala cromatica, così che il suo intervento ci appare straniante senza che si possa comprenderne immediatamente il motivo. Compare infine, come si è detto, la voce. Ma è una voce paradossalmente assente, è l’elusione della voce più che l’aggiunta del canto. È la maschera di Monteverdi che, sotto mentite spoglie, torna a giocare con noi la strategia musicale dell’inganno.
-
Un percorso di conoscenza
La scrittura è una via di conoscenza. Sono sempre stato affascinato dai percorsi che chiedono, aprono interrogativi. Attraversandoli esploro territori nuovi. Per questo la mia musica deve porre delle domande: domande a me, domande al pubblico che ascolta. Con essa cerco di fare i conti con quanto mi ha preceduto. È musica collegata con fili più o meno sottili con i tanti discorsi lasciati in sospeso dalla tradizione. Musica come drammaturgia della vita: non tanto manifestazione di un’arte manipolatoria, combinatoria del suono, ma soprattutto riflesso di un’esperienza umana. Carica di racconto, seppur priva della scena. Anche senza teatro, esistono molteplici forme di teatro.
-
Mondi di suoni diversi
La mobilità stilistica è la qualità indispensabile per accedere nei tanti aspetti, nelle tante tematiche dei soggetti sinfonici e teatrali. Ascolto la duttilità con cui lo strumento-orchestra viene trattata: una materia enorme, informe, capace di modellarsi sulla visione dell’arcata drammaturgica. I soggetti possono essere infinitamente vari e mutevoli. Per ognuno di essi deve essere individuato e poi plasmato il campo proiettivo della sua rappresentazione sonora. Shakespeare o la quotidianità: tutto può essere musica. Per ogni soggetto scelto, metto a punto una strategia di attraversamento di quel campo. A volte è il soggetto che mi suggerisce come definire l’opera da un punto di vista tecnico: mi indica il materiale, la chimica da alchimizzare, che può essere armonicamente ricca oppure aspramente rumorosa. Granulosa o morbida. In questo caso il soggetto rivela la strumentazione, definisce mondi di suoni diversi. Reinterpretare Shakespeare è possibile. La magia di quei testi, liquidi e incorporei, fa sì che riprendano perennemente forma, attraverso una nuova identità. Ponendo in rilievo elementi che sono attuali, aprendo infinite possibilità per lo stesso racconto. Questo è uno dei privilegi concessi al mito rispetto all’ideologia, che è così legata al tempo: porre di fronte alla storia, e all’arte, l’elemento dell’astrazione assoluta. Altre volte parto dal potere incantatorio di un suono, dalla visione di accorpamenti sonori, che hanno una loro forza intrinseca, una loro fisionomia teatrale. Li lavoro, li sviluppo, senza caricarli di un significato particolare. Anche in questo caso la mia musica racconta. Ma non in senso didascalico: è narrativa nel condurre in ciò che c’è dentro al suono, dalla massa magmatica orchestrale, sino ai segni più esili e filiformi. È una fabula dentro e intorno al suono. Che fa perdere la connotazione del suono stesso, che dimentica il suo significato comune. Reinterpretandolo dall’origine. È una partitura sempre stratificata, e ogni strato porta con sé un elemento drammaturgico. Una lettura e un ascolto che si compie a più livelli, un processo di conoscenza della musica che può essere compiuto da angolature diverse. Non mi piace dare per scontato nulla, e nemmeno offrire una sola visione d’ascolto. L’accesso a un livello via via più profondo della partitura è lasciato alla sensibilità dell’interprete e dell’ascoltatore. In questo modo resta sempre qualcosa da scoprire. Credo che la possibilità di contenere tante letture, di offrire tanti punti di ascolto, rappresenti la forza dell’opera d’arte in sé.
-
Fabula, Epos, Ludus
Attraverso i suoni narro il mio percorso di vita. Ho sempre amato il racconto, il senso di affabulazione tradotto in musica. Un racconto infinito, tramandato a ritroso e in avanti nel tempo, proiettato in una dimensione epica, assoluta. Insieme all’epico, si uniscono nella mia scrittura l’elemento poetico e quello ludico, surreale. Il gioco delle parti, lo scherzo di gesti sonori imprevedibili, la fantasia a tratti patafisica, la non paura del kitsch. La fantasia è uno sfogo. Realizza il desiderio di poter interpretare tutto ciò che mi succede, di poter leggere la realtà e assimilarla nella partitura. Sin da piccolo ho osservato ciò che mi circonda con il terrore per la sua sparizione. L’estinzione del mondo della mia infanzia, delle persone a me care, dei miei libri - come quelli di Jules Verne – posso trattenerlo in una composizione.
-
Artificio e natura
La dimensione di una scrittura immaginifica è il mio modo per relazionarmi al mondo, il modo più interno per stare a contatto con la realtà, per reagire con la musica a momenti dell’attualità dando una risposta di contenuti. Come nel caso di Afterthought, in cui traduco in suoni l’attentato di Londra. In questo racconto guidato dal suono, tutto è lecito. Anche l’utilizzo della tecnologia, che svolge sempre una funzione drammaturgica, compenetrata nella struttura dell’opera. Non è un elemento ornamentale, ma assume una funzione portante, quasi un prolungamento nel futuro, una protesi laddove i mezzi strumentali del passato non arrivano. La tecnologia video, la manipolazione del suono in tempo reale sono mezzi che rispondono alla domanda posta dall’orecchio di oggi, che è in continua evoluzione. Un orecchio di un presente che si modifica momento dopo momento. Anche nel caso di questa mutazione apparentemente incontrollata, non mi avvicino alla scrittura senza prevedere dove la mia musica vada a finire. Per I Cenci, ad esempio, ho concepito la possibilità di deformare Artaud attraverso una trasformazione dell’esistente inesorabile e graduale: l’elettronica dà voce all’immaginazione di Artaud, alla sua richiesta impossibile di sentire i suoni degli organi del corpo umano. La protesi della tecnologia funziona ed è bella quando la metamorfosi è misteriosa, arcana, non manifesta. Quando l’artificio non è riconoscibile. Quando l’effetto innaturale è indistinguibile dall’elemento naturale.